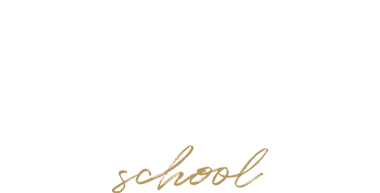Oriana Fallaci ebbe una netta avversione verso ogni tipo di progetto che la riguardasse: che si trattasse della trasposizione di un suo romanzo o il racconto biografico della propria vita. Il saggio, di cui anticipo un estratto per “Diari di Cineclub”, si propone di prestare ascolto alle ragioni della donna e l’intellettuale. Al contempo, vuole essere uno studio critico – dove l’indagine esistenziale, s’intreccia con l’analisi dello specifico filmico – quale introduzione del mio progetto filmico dal libro “Oriana Fallaci, Morirò in piedi” di Riccardo Nencini. Studio, rivolto agli spettatori del “film che verrà”, nella certezza che la presunta distrazione del pubblico verso un “cinema d’autore”, derivi principalmente dalla mancanza di adeguati strumenti di conoscenza ed approfondimento critico. C’è chi ritiene che la grande scrittrice non avesse una particolare affinità con il cinema, né fosse molto incline a frequentarlo quasichè lo reputasse il distoglimento dall’impegno e la ferrea disciplina lavorativa che ella stessa riconosceva come un “supplizio di Tantalo”: “ Se non produco molto, divento isterica e infelice, colpevole”. Di certo non era una spettatrice comune, e non lo sarebbe stata neppure (o soprattutto) se mai le fosse capitato di desiderare segretamente di esserlo. Non era comune – omologata, omologabile – la sua identità intellettuale attraverso cui le era difficile vivere un’esperienza creativa diversa dalla propria senza annettervi le sue intime motivazioni. In realtà se il mondo del cinema – inteso come “fabbrica dei sogni ” – non le era estraneo, giacché aveva avuto modo d’indagarlo nel suo debutto letterario “I sette vizi di Hollywood”, pochi famosi registi, attori/attrici, sono diventati suoi amici, e molto diversamente da quanto lo furono Sophia Loren, Anna Magnani, Pier Paolo Pasolini. Forse, per la sua connaturata estraneità etica ed esistenziale verso l’effimero, il clamore della ribalta. Per tentare di capire l’ “universo esperienziale” e ideativo che credeva non potesse essere scoperto/rappresentato da nessuno all’infuori di se stessa, occorre addentrarsi nella pieghe più nascoste della sua personalità: le prese di coscienza e i suoi conflitti interiori al prezzo del proprio isolamento. “Un libro aperto, scritto in sanscrito”, come l’ha definito sua sorella Paola. Oriana era ossessionata dall’affermazione della sua concezione di politica (in simbiosi con la libertà) e d’integrità morale, dalla strenua difesa di questa da ogni fraintendimento. Battersi a dispetto dell’“Alieno” – la malattia implacabile che aveva minato il suo corpo ma non il suo temperamento – per il trionfo della verità, era la sua missione. Il giornalismo e la letteratura, suo originario e dominante interesse: “Quando ero bambina, di solo cinque o sei anni, non concepivo nemmeno un mestiere che non fosse quello di scrittore: mi sono sempre sentita scrittore”- le hanno permesso di non tradire se stessa; non sempre di non venire tradita: dai lettori dell’ultima ora che sostenevano di non riconoscersi (più) nel suo “integralismo”. Ogni volta che l’emotività di donna prevaleva sulla razionalità d’intervistatrice/cronista/narratrice, non si vergognava della sua ingenuità”: “E’ una dote a cui tengo moltissimo perché si nutre della fiducia degli uomini, di amore per gli uomini: e tale amore, tale fiducia si scatena in me quando vedo gli uomini soffrire”. Ha avuto molti motivi per piangere: “Fa vomitare il dolore”, anche se quasi mai davanti agli altri, quando non le restava che “piangere asciutto”. Non aveva freni verso il coinvolgimento amoroso, né difese dinanzi al’ “infelicità” dell’anima”.“Infelice, si, Priva d’amore, di tenerezza. E, in sostanza di famiglia”. Scrivere, rappresentava la sua ricerca di una famiglia. Dare alla luce dei libri, amarli incondizionatamente come solo una madre può fare, era il suo modo di partorire dei figli, e come in “Penelope alla guerra” – suo romanzo-manifesto – era impossibile non scorgervi i tratti di una maternità: la reciproca somiglianza di una madre e suo figlio. Il suo grande timore era la profanazione di tutto questo. Era già accaduto a causa della traduzione, ritenuta inadeguata, di un suo romanzo; altre volte, con il tentativo di stesura non autorizzata della sua biografia. Ella credeva – con una dose ancor maggiore di apprensione – che potesse verificarsi per il cedimento al potere onnivoro del cinema; più propriamente de “il film”: Parlo di cinema, ma il cinema, si sa, non esiste. E’ una mera deduzione. Esistono solo i film, e da essi che si deduce l’esistenza del cinema, scriveva Pier Paolo Pasolini, che pensava/scriveva/girava da poeta prima che da regista, e con il quale Oriana si sentì in profonda sintonia. L’avversione della donna verso opere che “saccheggiassero “ il proprio privato o la sua letteratura – indifferentemente da chi fosse il suo interlocutore: un divo di Hollywood o un maestro del cinema mondiale – era mossa, appunto, da un timore; una sorta di vertigine dinanzi all’abisso. Paura, si può aggiungere, con l’iperbole che ha contrassegnato la sua vita, verso “un film” che non fosse, anzitutto, il racconto veritiero della (sua) realtà; l’Immagine di una passione: di un istante e di tutta una vita; la presa di distanza dalla storia per farne parlare i silenzi, secondo la lezione di Pierre Nora. Un racconto che narrasse se stessa per narrarle la nudità della sua anima; un viaggio nelle emozioni, nella solitudine della condizione umana e la propria; l’esplorazione di un sentimento vitale senza compromessi; quella della (sua) propensione alla sofferenza e al coraggio, alla lotta contro il sublime e terribile mistero della morte; la rappresentazione di un’esigenza d’amore totalizzante; quella, “rispettosamente impudica”, di una Donna. Lo strumento filmico va inteso, in tal senso, come ardimentosa alchimia, quanto il suo perpetuo rinnovarsi che ne racchiude grandezza e rischi. Ma trovo improprio affermare che Oriana fosse sospettosa verso un cinema/film in divenire e, in quanto tale, legittimato ad ogni tipo di trasgressione linguistica. Lo era, piuttosto, verso quello che riteneva prostituisse se stesso; che barattasse la sua autonomia espressiva con la convenzione e manchevolezza morale. Agli occhi della giornalista/narratrice, era impensabile una scissione tra comunicazione ed espressione – sguardo/oggettivo e visione/ soggettiva – tanto più se la forza evocatrice della parola doveva sostituirsi all’immagine audiovisiva, l’unità di tempo letterario a quella dello specifico filmico e la sua atemporalità. Una posizione, che rimanda alla presunta iniquità di fondo di qualsiasi proposito di trasposizione, alla lettera, di un’opera letteraria. Le soluzioni: optare per l’assoluta fedeltà alla fonte letteraria; propendere per la trasgressione linguistica, pur senza travisare lo spirito originario della fonte testuale. “Tradimento” dettato dalla visione registica. Difficile dire se l’intellettuale, anziché la narratrice, sia riuscita, intimamente, a superare almeno in parte le sue apprensioni; se sia stata mai, davvero, disposta a farlo. O se il suo vero motivo di timore sia stato la scoperta della sua insopprimibile vulnerabilità di fronte all’esposizione di sé. Ciò che si può immaginare, è che non le siano mai pervenute le risposte che desiderava e di cui aveva bisogno. Soprattutto quando si sapeva ormai prossima alla fine ed aveva iniziato, silente come non mai, a mettere ordine nella sua vita. La stesura del mio studio è stata dettata da una duplice esigenza: quella espressiva di autore/regista e studioso di cinema; quella morale, mossa dal rispetto verso la figura, di donna e di “scrittore” – come teneva a definirsi – di Oriana Fallaci, nella persuasione che il solo modo per tentare di rappresentarne l’identità, sia tramutare le sue parole scritte – “che emergevano come gocce, una alla volta, e rimanevano sul foglio… Ogni goccia diventava qualcosa che, se semplicemente detta, segue a pag. successiva Roberto Petrocchi n. 47 38 segue da pag. precedente sarebbe scivolata via…” – nella sua voce; il proprio innato spirito critico, in presenza ideale che si fa tangibile. Mi piace pensare che, in tal caso, ella avrebbe fatto ancora proprio l’appello degli studenti della Sorbona di Parigi, vergato sui muri durante il ’68: “Siate realistici, chiedete l’impossibile. La scelta di verità che sottende l’intuizione creativa. Quando la genesi di un’intuizione ideativa attiene a contenuti e racconto precostruiti – accade se la fonte (e non solo d’ispirazione) è letteraria o se l’oggetto è storico-biografico – l’incontro/confronto di un autore, in funzione della sua prossimità/distanza morale, prima ancora che estetica verso l’“autore terzo”, impone una scelta, a suo modo, etica. E’ quanto ho ritenuto dovesse riguardarmi, nel momento in cui sono stato investito dall’Idea, tanto affascinate e ardimentosa da bastare a sé stessa… , di rappresentare (filmicamente) – e comprendere, quale appagamento di un sorta di personale “furore di conoscenza” – l’identità “politica”, sentimentale ed esistenziale di Oriana Fallaci. Non solo a partire dalla lettura e rilettura delle sue opere, i numerosi scritti ed articoli, quanto dalla conoscenza di ciò che ne ha costituito la motivazione più profonda. L’identificazione, in altre parole, di quella “prossimità” di sé verso l’intuizione creativa, di cui s’è detto. La risposta mi è venuta dalla lettura del libro “Oriana Fallaci – Morirò in Piedi” di Riccardo Nencini, uomo politico, oltreché scrittore, che fu legato ad Oriana da profonda e reciproca amicizia, soprattutto nel periodo della malattia e del volontario isolamento della donna. L’opera di Nencini non è né vuole essere una biografia, ma la testimonianza di un sentimento di vicinanza e solidarietà umana; il resoconto, attraverso una prosa asciutta, antiretorica, di un confronto d’intelligenze, oltre ogni pregiudizio. Ho parlato, in riferimento alla presunta attinenza dell’Idea/“sollecitazione emozionale” con contenuti/racconti precostituiti, di necessità di una scelta etica. Aggiungo che quella verso cui la lettura del libro di Nencini mi ha indirizzato, è stata una scelta di verità. La sola, per quanto mi riguarda, che potesse sottendere l’Intuizione creativa, nell’accezione più estesa. Lo stesso realismo e “documento visionario”, in virtù dei quali “Morirò in piedi” abbraccia l’itinerario esistenziale, strettamente connesso a quello professionale, attraverso le parole ed i sentimenti della donna: i suoi rimpianti, i ricordi, la “lettura” del presente e l’interpretazione del passato, i momenti spiazzanti di speranza e di vis polemica, e quelli – che lo sono altrettanto – d’intima resa di fronte al disfacimento fisico e interiore, dovuti alla malattia. Itinerario che, momento dopo momento, attraverso la necessità – mai così esplicita – da parte di Oriana di confidarsi, traccia le ragioni dei suoi convincimenti e esplora la fatica con cui ne ha fatto la sua necessità di “scrittore”. Si pensi alle prime parole, al cospetto dell’amico: un atto d’amore, viscerale, struggente – anche se, in più di un’occasione, unilaterale – verso la sua Firenze: “Sono alla fine, Riccardo, e voglio morire a Firenze. Te lo avevo detto a New York. Ed ora ci siamo. Ma morirò in piedi, come Emily Bronte. Firenze è la mia città. Qui sono nata, qui sono sepolti i miei affetti, la mia gente. Qui ho iniziato a volere la libertà, quando ancora non sapevo cosa fosse. Parole, che sono, nel medesimo tempo, l’orgogliosa rivendicazione di una morte dignitosa: persuasa, da sempre, che la cosa più importante, fosse stata vivere con dignità, la donna ritiene, ora, che sia più importante morirvi. Nella confidenza – che è richiesta di aiuto ed auspicio di una condivisione sentimentale – vi è la premessa di un’esposizione di sé a cui sente di non potersi più opporre. L’occasione per un viaggio a ritroso nel tempo: divenuto sospeso, come i giorni che la separano dalla fine: era stata, fin lì, all’origine del suo ultimo libro, quasi concluso, sulla storia dei Fallaci, indietro fino al Settecento. Un romanzo polifonico che unisce le voci dei suoi genitori – dove s’incontrano l’ironia e la tragedia, la pietà e la speranza – ai racconti degli antenati. Nel viaggio da un presente che ha emesso le sue sentenze, c’è l’immagine-visione della bambina ingenua e curiosa, l’adolescente coraggiosa, divenuta partigiana con il nome di battaglia di Emilia, che portava le bombe a mano ai grandi nascoste nei cesti d’insalata. Quella ragazza diventerà Giò in “Penolepe alla guerra”, soggettista cinematografica: interessante rilevare come l’idea di cinema – inteso, soprattutto, come racconto-cronaca morale, s’affaccia in Oriana, proprio in occasione della sua prima esperienza letteraria. Giò scoprirà prevalere in lei i sentimenti di passione, angoscia, paura, amore. L’immagine della guerra, evocata dalle parole di Oriana nel libro Nencini, è quella deforme ed insopportabile dello strazio: il realismo forzatamente rimosso, lascia posto all’allucinazione; l’astrazione del dolore: negata qualsiasi spettacolarizzazione dello stesso. Così, i momenti che hanno visto Oriana giovane partigiana schivare cadaveri di suoi coetanei meno fortunati, quanto il ferimento e la “convivenza con la morte” da corrispondente di guerra, nell’inferno di Città del Messico nel ’68, divengono simbolo della dualità dell’essere umano: “feroce ed affascinante, angelo e bestia. La morte è un incubo, un’ossessione, ma talvolta è guardata quasi come una via di fuga, mentre la vita è una continua delusione e una lotta spietata tra infinite elusioni”. La donna ne ha rafforzato la convinzione negli anni della sua voluta e subita solitudine, ma non ha esitato a gridarlo al mondo all’indomani dell’attentato dell’11 settembre. Perche: “Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale.” E non importa se questo ha significato prestarsi alle dure critiche dei nemici e alle prese di distanza degli amici, tra cui Riccardo Nencini che le rimprovera di ostinarsi a vedere nella Chiesa l’unico baluardo contro la minaccia islamica; la sola fonte “alla quale attingere valori e certezze”. Il dissenso che più la sgomenta è quello di Tiziano Terziani, suo concittadino. Eppure, nonostante l’incontestabile antinomia culturale tra i due non è difficile cogliervi delle affinità, a cominciare dalla necessità di rifugio in un “posto dell’anima”: quello di Oriana, è stato tra le mura della sua casa, dove le era permesso, finalmente, di non essere più sola in mezzo agli altri, ma con sé stessa; il “posto” di Terziani è stato a 2700 metri d’altezza, ai piedi dell’Hymalaya e poi presso Orsigna – piccolo borgo dell’Appenino pistoiese (un ritorno alla sua casa, così simile a quello di Oriana), quando, prossimo alla morte anch’egli, aveva un unico desiderio: non aver bisogno di tempo per sé, ma quello che gli restava per gli altri. Se ogni momento del lungo e privatissimo incontro tra Oriana e Riccardo, esplora anziché limitarsi a raccontare una storia ed un’esperienza costellata di battaglie e prove sempre estenuanti, il più delle volte dolorosissime, è soprattutto l’Oriana, intimista, fragile, sincera fino all’autoflagellazione, a fare del libro di Nencini una confessione che coinvolge e segna nel profondo. Basti pensare al desiderio frustato di maternità e al suo dilemma dinanzi ad una vita implorante di nascere, che emerge in tutta la sua forza in poche – apparenti semplici – parole, ma più toccanti di ogni dissertazione etico-morale: “Due aborti. Se non avessi fatto quella vita… Tu hai figli? – chiede a Riccardo – Si, si, ricordo la dedica che ho scritto per…Si, Giulia..”- La primogenita dei tre figli dell’uomo: due femmine ed un maschio. Tre figli! Sei un uomo fortunato..”(…) Sai, avrei voluto, continuare “Lettera ad un bambino mai nato” E’ un inno alla vita, anche se il titolo può trarre in inganno. Non è un libro per sole donne..” Parole che esprimono un desiderio insopprimibile di vita, che conferisce operatività perfino a quanto precede la sua finitezza; un senso alla stessa, attraverso il potere della rimembranza: “Voglio morire nella torre dei Mannelli, guardando l’Arno dal ponte Vecchio. Era il quartier generale segue a pag. successiva diaridicineclub@gmail.com 39 segue da pag. precedente dei partigiani che comandava mio padre. Ci andavo da bambina..” Oriana si rivela ansiosa di “trasferire la memoria non scritta”; desidera che il testimone del proprio “diario parlato” sia Nencini, il cui merito è di farle avvertire il suo ascolto, che si tramuta in “ascolto” nel lettore. E che è divenuto anche il mio ascolto; ciò che ha definito le coordinate espressive della mia iniziale Idea di trasposizione filmica e la mia visione di cinema: non il semplice strumento per raccontare storie, ma tutto quello che ne è legittimazione. Una concezione di racconto che germina da un “immagine” la quale vive e germina oltre il racconto medesimo. In altre parole: pensare (per immagini) ad un racconto, prima che vi sia una “storia” da narrare; sempre che ve ne sarà una. Ciò accade, in modo ancora più sorprendente, se l’esigenza di immagini e di racconto – nella sua totale ambiguità assiologica – è trasmessa dalla realtà statica di un quadro, quanto dalle parole scritte di un libro. Una libertà di trattazione dello spazio ed il tempo, che interessa direttamente il rapporto tra realtà e immaginazione; la possibilità di spaziare dal realismo soggettivo e al soggettivismo visionario. Potrei dire che il libro di Nencini – e qui che risiede, dal mio punto di vista, un rilievo espressivo che va al di là dell’intensità della prosa – conferisce potenza visionaria alla narrazione e alla cronaca. Fatica / passione del vivere e “corpo a corpo” con la morte di un’atea cristiana “…Un giorno camminavo sui sassi, quando mia madre esclamò: Coraggio, va avanti! Prendimi in collo, risposi, c’è i sassi. E lei: il mondo è pieno di sassi, te ne accorgerai presto”. Nel racconto di Oriana bambina, ma già spronata a pensare e fronteggiare le difficoltà con lo spirito d’adulta, c’è l’istantanea di tutta la sua vita. Lo svezzamento alla fatica e la sofferenza che – aveva compreso – muove l’intelligenza; l’abitudine – prima forzata, poi difesa – al coraggio con i volti della “generosità, della vanità, della curiosità, della necessità, dell’orgoglio, dell’innocenza, dell’incoscienza, dell’odio, dell’allegria, della disperazione, della rabbia, e perfino della paura”. Perché è questo che comporta la venuta al mondo, ma è anche il fondamento della passione più incrollabile. Lotta, patimento, desiderio di esplorazione, come itinerario di “educazione sentimentale” – di bambina, adolescente, di matura che ha cessato di nutrirsi di sogni ed illusioni senza rinunziare mai alle emozioni – e formazione culturale/intellettuale: dal suo rapporto, ombelicale, quasi bulimico, con i libri, l’apprendimento del senso dell’esistere, l’esigenza di conoscenza dell’indole umana; l’amore per la vita nella contemplazione della natura, la quieta mutevolezza e il procrearsi degli alberi. Vita – che “non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere” – come “arcobaleno inesauribile di colori, concerto interminabile di rumori, caos fantasmagorico di voci e di volti, creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino”. Amore del vivere nato nella donna assieme al suo “corpo a corpo”, altrettanto precoce, con la paura e la morte. Non la temeva – l’odiava, era incapace di accettarne l’idea – perché l’aveva conosciuta sin da bambina, quando da staffetta partigiana aveva un unico timore: non riuscire assolvere la missione affidatale. Ma alla morte non s’è mai abituata, e non ha mai pensato che potesse essere salvifica: “Io non ci credo alla buona-Morte, alla dolce-Morte, alla morte che Libera-dalle-Sofferenze. La morte è morte, e basta.”, né s’è mai abituata all’idea della guerra; non avrebbe potuto. Lei che aveva attraversato devastazioni, conosciuto l’odore nauseante di corpi in brandelli, l’umiliazione di umanità e terre senza più confini: perché nessun terra di morte e sopraffazione può averne. Non c’è stato momento in cui Oriana non si sia interrogata sullo scandalo del fine di una vita, l’insensatezza della negazione di questa che la scomparsa dei nostri affetti, per prima, ci svela: la privazione dell’uomo, della donna che amavi; di chi ti ha dato la vita, che è “l’anticipo della tua morte. Perchè la morte della creatura che ti ha concepito”. E come trovare risposta di fronte alla menomazione della mancata – voluta o subita – maternità? Sottrarsi alla possibilità di venire giudicati da chi ha a cuore la Vita assieme a chi tiene in giusto conto le ragioni della nostra di vita? La sua risposta, l’unica possibile, una lettera al (suo) bambino mai nato, l’essere per cui una donna vive e spera, finché non accetta l’idea che quella impellente “promessa di vita” resti tale: per l’imperscrutabile disegno del destino, per viltà ed egoismo. La sfida delle sfide era la lotta impari contro la morte. Ma ciò che più la turbava non era la fine corporea, quanto il nulla dopo di essa; la dimensione oltre la quale non c’è coscienza, né sofferenza: estremo sintomo vitale. E’ l’origine del suo “male dell’anima”: Incredibile come il dolore dell’anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia si mettono subito a strillare: presto-barellieri-plasma; se ti rompi una gamba te la ingessano, se hai la gola infiammata ti danno le medicine. Se ha i il cuore a pezzi e sei così disperato che non ti riesce ad aprir bocca, invece, non se ne accorgon neanche. Eppure il dolore dell’anima è una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata. “L’unica speranza è Dio, ma io non ci credo”, scrisse il poeta Dario Bellezza. Allo stesso modo, “Ricorrere all’idea di Dio è un espediente mai capito e mai accettato” da Oriana, dal giorno in cui, appena bambina, aveva perso la fede, a seguito di un piccola/ grande ingiustizia subita. Si definiva atea perché riteneva che Dio fosse stato creato dagli uomini – non il contrario – per vincere la propria innata solitudine e infelicità. E, tuttavia, non mancava di rivendicare il suo cristianesimo, da cui sentiva di non poter prescindere perché apparteneva alle sue radici, quelle della civiltà occidentale per la difesa delle quali s’è battuta strenuamente fino alla fine. Il suo Cristo è colui, a partire dall’incarnazione, che crede nell’Uomo; il suo Verbo riguarda la speranza, il rifiuto della morte. Cristianesimo, dunque, come esaltazione della Vita, che Oriana amava – pur senza credere alla Resurrezione – incondizionatamente. In punto di morte, soffrendo, alzò gli occhi e gridò: ‘Se Tu esisti davvero, perché non mi fai vivere’. Non chiedeva di non farla soffrire, chiedeva di vivere” – ricorda Monsignor Rino Fisichella, rettore dell’Università Lateranense, con cui la donna – dichiaratamente anticlericale, ma con una profonda ammirazione per Papa Benedetto XVI – aveva un rapporto di sincera stima ed amicizia. La vicinanza che l’alto prelato ha mostrato verso la donna, soprattutto nel momento del trapasso, rappresenta il momento cruciale di quello che lo stesso Fisichella ha definito “il suo desiderio di Dio”. Una morte – coerente con se stessa – da atea-cristiana; non riconciliata ma serena, proprio perché non vi è stato alcun proposito di forzare la sua conversione, come ella aveva quasi intimato. La lettura per “immagini visionarie” di un contenuto testuale, interessa, per quello che mi riguarda, ogni possibile implicazione emotiva / emozionale, linguistica, estetica. Quella del mistero insondabile della vita, il patimento della solitudine a cui la stessa ci destina, la necessità/assenza di Dio dinanzi alla morte come mancata rinascita – temi centrali, come s’è visto, nella vita ed esperienza di Oriana Fallaci – ha innescato l’”idea filmica” della rappresentazione scenica a cui aspirare; a complemento, se mi è concesso dire, della vocazione – e l’universo interiore che serba in sé – propria della donna: quella dello “scrittore” la cui parola e la ricerca metrica, intesa come espressione, è il tramite di esplorazione/rivelazione della – sua – realtà. Ella, che pure non ha mai coltivato una vocazione saggistica in senso stretto, non voleva che questo. L’idea filmica è quella del “non luogo”, lo “spazio dell’anima”, che ha i contorni di una stanza disadorna, dominata dalla penombra, come lo è la pluralità della coscienza e delle passioni, della memoria. Unici elementi di arredo riconoscibili: un orologio a pendolo e un antico specchio; nessuna via di fuga, nessuno accesso al segue a pag. successiva Oriana Fallaci (Firenze 29 giugno 1929 – 15 settembre 2006 sepolta nel Cimtero degli Allori – Fi) n. 47 40 segue da pag. precedente “mondo fuori”, tranne una finestra da cui proviene un fascio di luce diurna, fievole ed immutabile. L’atemporalità che vi domina, rimanda all’astrazione dell’allestimento scenico teatrale, anche in termini di metafora: si pensi alla “stanza della tortura” a cui fa riferimento Giovanni Macchia nel suo saggio dedicato al teatro pirandelliano: vi si immagina sequestrata un’umanità martirizzata da sé stessa, con i suoi segreti, le sue piaghe, i suoi dilemmi. Così simile allo “spazio”/rifugio/prigionia dove trova posto la meditazione/espressione etica/morale, come radice di sofferenza, che evoca l’intimità inquieta di Oriana. Perché è difficile comprendere – con le parole del poeta tedesco Gottfried Benn – quale fardello si prenda su di sé quando si esegue il proprio compito interiore, contro il quale si conoscono esattamente tutte le obiezioni e che pure bisogna difendere, una volta cominciato”. Al di là della contaminazione linguistica tra teatro e cinema, l’intuizione filmica delineata è frutto, come ha avuto modo dire, di una suggestione visionaria: l’”oggetto spazio” si fa espressione del divenire/sentire dell’”oggetto-sentimento/emozione, al pari dell’”oggetto-tempo” così presente nella vita di Oriana: “Non avrai molto tempo per capire e fare le cose. Il tempo che ci danno, quella cosa chiamata vita, dura troppo poco. E così bisogna che tutto accada molto in fretta”. Una esigenza a cui non si è mai sottratta. Incosciamente, o meno, la sua smania di collezionare ogni cosa: vasi etruschi, piuttosto che telefoni fuori uso, orologi antichi ed abiti orientali, fino a barattoli di farmaci (oggetti rari e preziosi assieme ad altri assolutamente inutili, confusi nel disordine più totale ), era il suo modo per fermare il tempo. Ella non temeva la vecchiaia: i segni del decadimento fisico erano le sue “medaglie guadagnate, un’occasione di libertà assoluta, sconosciuta da giovani”. Motivo di angoscia, piuttosto, era non aver trovato le risposte con cui sarebbe stato giusto morire, nel momento in cui il futuro le appariva così breve da sfuggirle di mano come fosse “sabbia che cola dentro una clessidra”. Dominante era il rifiuto dell’idea che il flusso temporale di avvenimenti pubblici e privati – gli uni, sovente, strettamente connessi agli altri – rispondesse al disegno insondabile del destino. Il tempo scandito dall’orologio scenico non è costituito dal susseguirsi di secondi, minuti, ore, ma dalla percezione dell’ineluttabilità del suo consumarsi; in altre parole, di ciò che conferisce un carattere illusorio alla realtà. Nell’altro elemento d’arredo citato – l’antico specchio – all’immagine riflessa del volto solcato dalla malattia di Oriana, si sovrappone e si sostituisce quella immateriale della “mutilazione dell’anima”. Il sentimento d’amore – coniugale, materno – affannosamente inseguito per tutta la vita, assume, allora, i morsi del rimpianto. La suggestione visionaria descritta è espressione dell’ambiguità propria dell’immagine filmica. E, tuttavia, la “menzogna” del cinema media, non trascende, in questo caso, l’oggetto verità/umanità che attiene all’universo interiore della donna. Si pensi alla finestra della stanza, unica via d’accesso al “mondo fuori”. Una via d’accesso solo visuale, e altro non potrebbe essere. Ma è in virtù di questa, che Oriana scorge l’immagine, inaspettata e catartica, del mare di Viareggio: intimamente agognata prima che la morte avesse il sopravvento. Sentimento dominante e “narrare della luce” L’Idea filmica mossa dalla mia lettura del libro “Morirò in piedi”, ha come presupposto la sua proliferazione in “alone creativo”. In altre parole, l’abbandono al flusso d’“immagini alogiche” e loro complessa convivenza, che rimandano al “sentimento dominante”. Condizione all’infuori della quale l’espressione artistica resta confinata nell’alveo della irrisolutezza. Nella vicenda esistenziale di Oriana Fallaci, così come si dipana nel “diario parlato” al centro del libro di Nencini, il sentimento dominante è rintracciabile nel “segno”, inteso come forma ed espressione; determinazione prioritaria dell’immagine filmica, isolata dalla sua “giustificazione” drammaturgica. La macchina da presa acquista, allora, la funzione di governare lo spazio – scenico – in funzione della “corporeità”/tramite emozionale, dei protagonisti che lo abitano: Oriana e Riccardo (ci) parlano e “vivono” oltre la parola. Le “invocazioni dell’anima” della prima, sono – di riflesso – anche quelle del secondo, in virtù dell’impudicizia di un incontro che ha il potere “destabilizzante” di rafforzare un desiderio di condivisione. E se il rincorrersi del “buio e della luce” a cui appartengono le emozioni più riposte, suggerisce il ricorso al “piano sequenza”, il “narrare della luce” è il segno, che racconta l”’irruzione del dramma”. Il concetto di “narrazione della luce”, va riferito da una parte a una concezione dell’illuminazione scenica che supera l’artifizio tecnico per divenire essenza stessa del racconto; dall’altra, ad una “condizione” estetica, nei suoi valori cromatici e figurativi, che rimanda alla pittura. Ha scritto il direttore della fotografia Renato Tafuri: “La differenza tra l’operatore di macchina e il pittore è che il primo inizia dal nero ed il secondo dal bianco. E’ dal nero, infatti, che personalmente parto; da questo che incomincio a mettere la luce che mi occorre, come tonalità, come scuri e come croma”. La contaminazione in termini di rappresentazione scenica, tra arte figurativa (statica) e immagine filmica (in divenire), conferisce a ciò che compone quest’ultima – cose, oggetti, persone – il potere d’evocare lo svolgimento drammaturgico, proprio della pittura; in particolare di taluni movimenti espressivi. Il riferimento più immeditato è a quello della nuova oggettività e il Realismo europeo. Con l’aggettivazione negativa del concetto di umano esso proponeva un ritorno alla realtà oggettiva, pur nelle differenze dei vari rami espressivi: quello dell’esaltazione drammatica, conseguenza della crisi del dopoguerra, e quello purista del “Realismo magico” proprio di quelle correnti che professavano il ritorno ai “valori plastici” del Novecento italiano. Se ci si riferisce, tuttavia, ad una “narrazione della luce” nello stretto contesto di trasposizione filmica del libro Nencini, i modelli – relativamente, come detto, ai valori sia cromatici che figurativi – oltre ad essere catalogabili in termini di “movimento pittorico”, lo sono in quelli di singolarità dell’”opera”. Basti pensare alla “stanza” come luogo dell’anima, che pure racconta la dolorosa fisicità di Oriana all’insegna dell’iperrealismo. Il raffronto è alla “cruda umanità” di Lucian Freud: l’artista guarda dentro la carnalità del protagonista, prigioniero dello spazio di cui, egli stesso, sembra avere, solo in parte, coscienza. Spazio d’intimità e patimento. Dell’anima, appunto. Si pensi, ancora, all’immagine onirica dell’”inferno” di Città del Messico: l’oltraggio della devastazione delle carni e della morte, rimanda all’ astrazione del dolore dell’opera di Kathe Kollowitz, dove il sentimento di compassione e comprensione verso le categorie sociali più disagiate, si traduce in termini pittorici in una narrazione della luce che “vive” proprio in virtù della negazione di ogni riferimento nudamente figurativo. Così come avviene, per felice contrasto, nella drammatizzazione filmica dei “tempi morti”: mi riferisco a momenti nei quali non è l’oggetto/soggetto ad abitare la scena ma l’”assenza” di questi; la narrazione della luce, nello specifico, riguarda ciò che lascia posto al silenzio dell’inconoscibile: presagio di vita/morte, desiderio di fuga verso un’’altrove” di cui si disconosce l’esistenza, vuoto di fronte al mutismo dell’anima e l’assenza di Dio, abisso che precede il dissolvimento della speranza. Un “vuoto”, nel quale è possibile “vedere” quello – mai colmato – che ha accompagnato l’intera esistenza di Oriana Fallaci. E’ attraverso questo vuoto che è silenzio, isolamento interiore, che ella ha imparato ad interrogarsi, a sfidare la sofferenza e a decidere di lottare per la libertà – anche di appartarsi al mondo – non arrendersi alla malattia e della morte.
Roberto Petrocchi
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto
Oriana Fallaci il film temuto