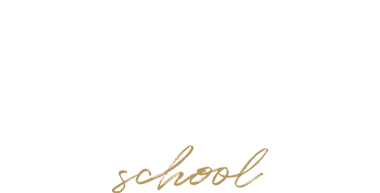Progetto di trasposizione cinematografica
dall’omonimo romanzo di Paola Capriolo
Ed. Bompiani
soggetto e note di regia
di ROBERTO PETROCCHI
Ottobre 2010
Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione, anche se parziale, della seguente documentazione
Soggetto
Imprecisata località marittima del nord Europa, ai nostri giorni.
Nadine, giovane infermiera di colore, scruta l’impetuosità del mare in inverno da una spiaggia nelle vicinanze della clinica psichiatrica dove lavora. Persa nello spazio incontaminato attorno a sé, nota in lontananza una sagoma scura: sembrerebbe un grosso pesce, o un relitto trascinato a riva dalla marea. Soltanto quando vi giunge a pochi passi, scopre che si tratta di un ragazzo con indosso un frac…
Di lì a poco Nadine torna sulla spiaggia in compagnia di un medico e di due lettighieri. Ma quando s’accinge ad indicare loro il luogo dove ha visto lo sventurato sconosciuto, questo sembra inspiegabilmente scomparso.
Proprio nel momento in cui il medico si vede costretto a fare ritorno alla clinica e a richiamare a sé i lettighieri, uno di loro scorge la figura di un giovane dinoccolato sgusciare tra vecchi capanni riservati un tempo ai bagnanti, le cui sembianze corrispondono a quelle dello sconosciuto scoperto poco prima da Nadine.
Ricoverato in clinica e al cospetto del direttore sanitario, il ragazzo risulta sprovvisto di documenti e, come se si trovasse ancora smarrito a vagare nella spiaggia deserta, si rivela incapace di pronunciare una sola parola. Ricevute dallo psichiatra carta e penna, anziché scrivere il proprio nome disegna un pianoforte a coda.
Per i sanitari non resta che vagliare l’indizio alla prova dei fatti, mettendo lo sconosciuto di fronte ad un vecchio, ma ancora funzionate, strumento presente nel giardino d’inverno della clinica.
L’esperimento non sembra sortire alcuna risposta, cosicché i medici intervenuti tornano alle loro abituali occupazioni, lasciando il ragazzo in compagnia di Nadine.
Quando anche la ragazza desiste dall’attesa e s’accinge a chiedere l’intervento degli infermieri per far accompagnare il paziente nella sua stanza, accade qualcosa di strabiliante: le note di una melodia, carezzevole ed inquietante, invadono ogni angolo della clinica. E’ lo sconosciuto ad eseguirla, con una maestria prodigiosa.
Nei corridoi più vicini, poi in quelli più lontani, le porte delle stanze della clinica si spalancano una ad una; medici ed infermieri si affacciano sulla soglia tendendo l’orecchio, imitati dai pazienti.
Per alcuni di costoro, l’ascolto della musica diviene un appuntamento da non mancare: ogni volta che il “pianista muto” esegue con trasporto le sue melodie, si ritrovano riuniti ad ascoltarlo in religioso silenzio. Giorno dopo giorno, quella musica – che spazia da Chopin a Schubert, da Schumann a Debussy, Listz – ha il potere di metterli di fronte ai fantasmi delle loro travagliate esistenze.
Accade così che l’anziano Rosenthal, ex deportato nel campi di sterminio nazisti, riviva attraverso le note di un dolente Lied della Winterreisse” di Franz Schubert, il sentimento lacerante del rimorso, allorquando si rivede inerte di fronte alla dipartita del suo compagno di sventura Isaac, giovane pianista: come il pianista muto, custode del suo segreto, in grado di toccare, proprio con le note di Schubert, l’anima di ognuno dei segregati del campo.
Solo in apparenza terapeutica e altrettanto dolorosa si rivela la musica per la signora Doyle, macchiatasi dell’atroce colpa di omicidio del proprio figlio, di cui ha rinnegato la maternità. Mentre nella contessa – una nobildonna decaduta, ossessionata dal vano inseguimento del tempo che fu – e nel signor Brown – compìto contabile che al potere seduttivo della musica ha sempre anteposto un’esasperata razionalità – le note del pianista hanno l’effetto di ridestarli alla vita.
Nell’animo dei pazienti la musica ha un effetto bifronte: drammatico nel caso di Rosenthal; inquietante e non solo inconsciamente autopunitivo, per la signora Doyle; catartico, un’estasi felice, per il signor Brown e la contessa.
In Nadine che, a differenza di tutti gli altri, l’ascolta appartata, dà luogo ad un sentimento d’amore senza condizioni verso il pianista muto, il cui mistero resta insondabile: nella psiche del ragazzo le note di Schubert e, diversamente, quelle di Chopin, di Schumann, che esegue quasi ne fosse un alter ego, fanno riaffiorare oscure tracce del proprio vissuto.
Al contempo, la musica rievoca nella ragazza momenti della sua intima infelicità. La svagata fantasticheria che ha preso il posto di una vita non vissuta: lo spettacolo inebriante e sconosciuto, per lei cresciuta in un tetro agglomerato suburbano, della vastità del mare; il volto sognato della mamma naturale che non ha mai conosciuto, sovrapposto a quello straziato della mamma adottiva di cui ha condiviso l’esaltazione e la pena, proprie della vocazione artistica; l’amore per il pianoforte e la musica; il desiderio infantile, mai appagato, di vedersi rimboccare le lenzuola dalla nonna, sentirsi raccontare una fiaba dove il bacio di un principe vince un maligno incantesimo e richiama alla vita. Ricordi che la fanno piangere, ma che sembrano guarirla.
Tra il pianista muto e Nadine si instaura misteriosamente un’affinità elettiva e spirituale, sancita dalla musica: tramite della lingua scritta; “distanza” dalla parola, capace di far sentire il sentimento.
Nadine prende a scrivere al ragazzo delle lunghe lettere nelle quali parla dei propri sentimenti, di sé e dei suoi ricordi, con il timore – il presentimento – che il destino separi le loro vite, così come le ha fatte incontrare. Ma per pudore, o forse per non infrangere una sorta di sortilegio, si astiene dal far pervenire le lettere all’oggetto del suo amore: idealizzato come lo è stata la sua vita.
Una notte, un grido disperato irrompe all’improvviso nella clinica: è quello di Rosenthal, dolorosamente oppresso dagli incubi del proprio passato. Visitato dai sanitari, all’uomo viene proibito di esporsi alla perturbazione della musica, così ossessivamente presente nei sui ricordi. La privazione non passa inosservata al pianista muto che, attraverso le note del suo pianoforte, sembra esprimere la “solitudine dell’anima”, propria e di Rosenthal. E quando questi decide di mettere fine ai propri giorni, lasciandosi morire assiderato nella sua stanza, si verifica nel ragazzo una sorta di shock psicologico che ha l’effetto di restituirgli il misconosciuto passato, ma anche d’impedirgli di continuare a suonare. Egli decide, così, di fuggire dalla clinica, ma prima di farlo, scrive una lettera a Nadine, la cui vicinanza e le pudiche premure lo hanno liberato dai suoi spettri, quanto il suicidio di Rosenthal lo ha rivelato a se stesso.
Il ragazzo va da Nadine per consegnarle la lettera ma, in sua assenza, scopre quelle scrittegli da lei e mai recapitategli, restandone profondamente turbato al punto da riacquistare la parola, sebbene per il tempo fugace di dire laconicamente addio alla ragazza e scusarsi con lei per questo.
Quando Nadine trova nella propria stanza la lettera-confessione del ragazzo, di questi non vi è più traccia.
Medici ed infermieri, a cui fanno da corona perfino i pazienti della clinica, si ritrovano a perlustrare la spiaggia palmo a palmo. Non Nadine che ha scoperto, prima degli altri, delle orme dirette verso il mare…
Al direttore della clinica non resta dichiarare la morte presunta del ragazzo. E con la consapevolezza di aver fallito come medico, che avvinto dal “caso” scientifico ha colpevolmente ignorato quello umano, decide di rassegnare le dimissioni dalla clinica.
Nadine continua, per anni, a prestare il suo lavoro presso la clinica con lo zelo e la discrezione di sempre. Segretamente, ella coltiva la speranza che il pianista muto, venuto e scomparso nel nulla, torni a pigiare i tasti dell’ormai polveroso pianoforte, restituendosi e restituendola alla vita.
Note di regia
Più volte ho manifestato a Paola Capriolo alla quale sono legato da stima ed amicizia, nata in occasione della mia trasposizione filmica del suo racconto “Il gigante” (nel libro “La grande Eulalia”, con cui s’è imposta all’attenzione di critica e pubblico), l’auspicio che le nostre esperienze tornassero ad incontrarsi, persuaso che un fruttuoso rapporto tra cinema e letteratura implichi sempre un “comune sentire” tra scrittore e regista, pur nel rispetto delle singole diversità linguistiche/espressive. La lettura de “Il pianista muto”, del quale Paola mi ha fatto omaggio con dedica, come sempre all’uscita di un suo libro, mi ha convinto che quell’auspicio doveva trovare il suo compimento.
Al contrario di altre sue opere, la vicenda narrata è ispirata ad un episodio realmente accaduto: il ritrovamento, su una spiaggia deserta, di un uomo senza identità né memoria, rivelatosi uno straordinario pianista prima che se ne scoprisse l’inganno.
Confesso che il misterioso personaggio suscitò anche il mio interesse, tanto che pensai di raccontarne la storia in un film. Ma cosa narrare – mi sono chiesto – e con quale chiave espressiva? L’esplorazione del lato più insondabile della psiche e, con essa, una riflessione sul potere introspettivo della musica? Un viaggio d’impronta metaforica nel passato, rivelatore dell’identità più riposta di ognuno?
In virtù della capacità di Paola di conferire sorprendente compiutezza espressiva alla materia narrata, l’idea di tradurre in immagini sentimenti ed emozioni, prima che un susseguirsi di accadimenti, è stata la risposta alle mie domande; l’inizio di un’affascinante avventura.
Persuaso che “vedere” il proprio film prima d’iniziare a girarlo sia una condizione imprescindibile per un scrittore di cinema – come lo è, o dovrebbe esserlo, per un pittore, uno letterato, un musicista, vedere/”leggere”/”ascoltare” la propria opera, prima di darne vita materialmente – vorrei qui soffermarmi su quelle che sono le istanze narranti e le soluzioni drammaturgico-espressive nella prospettiva della trasposizione filmica del racconto; vale a dire, l’insieme dei miei criteri registici.
Se taluni brani del racconto hanno scarsa ragione d’essere lontano dalle pagine del libro, diversi sono gli spunti tematici che rappresentano una rilevante materia espressiva. Primo tra tutti quello della patologia mentale, intesa come disagio esistenziale, necessità/incapacità di dare un senso alla vita, comprendere/rimuovere il passato; del male d’amore, conseguenza di un sentimento ossessivo e divorante. Temi, che assurgono a metafora del mistero della solitudine della condizione umana, la cui universalità è espressa dal potere della musica di destare il tempo, citando Thomas Mann.
Quando si parla di malattia mentale, il pensiero va all’esistenza di patimento, la “vita senza domani”: toccante titolo del diario segreto di una ex degente di quello che fu l’Istituto psichiatrico di Trieste; alle vite trascorse, talvolta per lunghi anni, in luoghi di segregazione e coercizione, quali sono stati i manicomi. Tutto questo mentre hanno imperato le più diverse interpretazione del fenomeno: patologia della psiche; disturbo della mente, conseguenza di alterazioni psicologiche, problemi sociali, fattori culturali, conflitti familiari.
Il cinema s’è occupato più volte e con diverse visuali del fenomeno della malattia mentale, pervenendo ad esiti talvolta rilevanti: è il caso di “Qualcuno volò su nido del cuculo” di Milos Forman, dove l’istituzione manicomiale è vista come ordine malefico e dittatura della scienza sull’umanità. Ma non va trascurato, a mio parere, il cinema off di Silvano Agosti, che con il suo film “La seconda ombra” racconta l’”evasione”, dalla segregazione e le violenze di un paziente del manicomio di Gorizia, attraverso la sua “seconda ombra”; vale a dire “il destino che ogni persona non ha vissuto. Perché ogni persona dovrebbe chiedersi se sta vivendo il destino che si era
preconizzato e che voleva vivere”, secondo le parole del protagonista.
A fronte di tali rappresentazioni/interpretazioni, ciò che ritengo espressivamente pregnanti nel racconto filmico è la traduzione del “buio della mente” in disagio esistenziale, “buio dell’anima”; riflessione filosofica sull’angoscia del vivere, la vacuità dell’esistenza, l’incapacità di avere coscienza di sé. La descrizione di mondi paralleli, dove trovano posto il sovvertimento dei sentimenti, l’opporsi senza speranza all’imponderabilità del destino, la vertigine della morte interiore, la pericolosa evasione dal torpore del cuore e dell’esistenza.
La clinica psichiatrica descritta nel romanzo è un luogo “altro”; uno spazio, inteso metafisicamente, dove albergano il subbuglio dell’anima e dei sentimenti. Eppure, al suo interno regna l’ordine estetico, la meticolosa ricerca dell’armonia. Ne è espressione il giardino d’inverno dove trova posto il pianoforte, quasi che la sola sua presenza possa irradiare di rasserenanti melodie ogni anfratto; non vi sono stanze d’isolamento, camice di forza, terapie coercitive, elettroshock, e neppure il “lettino dello psicanalista”: immagine simbolo dell’intervento terapeutico, del malessere psichico prima che psichiatrico. I pazienti che vi sono ospitati non hanno menti malate ma anime, fatta eccezione per il personaggio della signora Doyle, figura simbolica dello sconfinamento del malessere esistenziale in follia; essi scoprono, grazie alla musica, la necessità di svelarsi a sé stessi, attraverso la rievocazione di un passato mai rimosso. Si pensi a Rosenthal che arriva al gesto estremo del suicidio, scoprendosi incapace di convivere con il ricordo; ma anche alla “follia” d’amore di Nadine per il pianista muto, che riporta alle grandi eroine del melodramma italiano.
Soffermandomi sull’impianto drammaturgico ed i suoi snodi – nella trasposizione filmica / la successione delle scene e delle sequenze, il “conflitto” – ho in mente una narrazione dominata dall’ambivalenza: dei personaggi (l’indecifrabile rapporto di convivenza tra i pazienti, ed in particolare tra costoro e il pianista muto; la misteriosa affinità, tra quest’ultimo e Nadine, in virtù della musica) e della collocazione scenografica / temporale, teatro dell’intera vicenda. Penso al “non luogo” del ritrovamento del pianista muto – un “mondo fuori” che travalica i confini del tempo -, così come, per molti versi, l’interno della clinica psichiatrica. Una lettura, potrei dire, nella direzione della poetica del realismo visionario, oggetto dei miei studi da qualche anno a questa parte ed espressione della mia attuale visione di cinema.
Costruzione filmica
Ciò che più m’interessa, è porre al centro del racconto filmico la perturbazione ad opera della musica; il parallelismo tra perturbazione dell’anima subita dai pazienti, e quella dell’esistenza / del cuore, (dell’anima in senso romantico), che accomuna il pianista a Nadine, ma al tempo stesso li distingue: densa di fantasmi l’esistenza del primo; non vissuta e “malata” nell’inseguimento di un sentimento d’amore assoluto ed impossibile, quella della seconda.
Nel disvelamento del mondo interiore dei protagonisti attribuisco grande importanza all’apporto di elementi squisitamente filmici quali: la scelta dell’inquadratura, i movimenti di macchina, lo studio della scenografia, la fotografia, il montaggio.
Riguardo alla composizione dell’inquadratura, la scelta dei movimenti di macchina e l’articolazione del montaggio, è mia intenzione superare il mero criterio estetico conferendo alla rappresentazione filmica una connotazione fortemente simbolica. Se mi sono concessi dei motivi d’ispirazione, potrei citare: “Un mondo di Marionette” di Igmar Bergman, dove attraverso la rappresentazione della psicosi, che sconfina nell’assassinio, di un uomo all’alta borghesia benvoluto da tutti e all’apparenza gentile, il regista svedese mette in scena il vuoto psichico, l’angoscia e la solitudine interiore, scomponendo e ricomponendo la scansione del tempo, con immagini, oserei
dire, brechtiane: spiazzanti e rigorose, al tempo stesso. Un’opera – anche in considerazione del fatto che è stata girata in Germania, a Monaco di Baviera, con produzione tedesca – in cui Bergman sembra subire il fascino, a livello iconico più che espressivo, della nuova cinematografia di quel paese, che avuto i suoi massimi rappresentanti in Wenders, Erzog e Rainer Werner Fassibinder. Proprio in uno dei film più affascinati di quest’ultimo, “Veronika Voss”, ho identificato un secondo motivo d’ispirazione; da un’ottica puramente formale: l’atmosfera sospesa, il bagliore delle immagini e la sensazione di straniamento che ne consegue; ma anche, per molti versi, dal punto di vista tematico: l’ossessione degli spettri del passato, frutto delle alterazioni della mente e del disagio esistenziale.
Fotografia
La composizione dell’inquadratura non può assolutamente prescindere, nella mia idea di cinema, dallo studio fotografico. In tal senso ritengo utile fornire, già in questo contesto, delle indicazioni a chi si occuperà dell’illuminazione della scena, ma anche agli attori che la abiteranno.
Tornando a riferirmi al realismo visionario, immagino un “narrare della luce” che tragga ispirazione ad opere ed artisti che ne sono state, variamente, espressione; penso, in particolare, alla neovisionarietà propria del movimento pittorico italiano nel ‘900 fino all’inizio di XXI secolo. Un’intuizione espressiva che si fonda su un ritrovato rapporto con la coscienza, l’inconscio e la sua forza propulsiva. Un universo d’immaginazione, illusione; l’interpretazione – prima che la rappresentazione – della realtà. Penso alla pitto-fotografia di Francesco Paolo Michetti, filosofo oltre che pittore, nelle cui opere convivono intimismo lirico e simbolismo. La successiva scelta a favore della fotografia coincise con una profonda revisione della sua visione pittorica e ne testimonia l’inclinazione verso nuovi strumenti espressivi: oltre alla fotografia, il nascente cinema.
I pittori/poeti dell’immaginario nelle cui opere ho rintracciato l’immagine filmica che ho in mente, sono Fabrizio Clerici e, con salto a ritroso di oltre 170 anni…, Johann Heinrich Fussli. Un’opera, quella di Clerici, pittore visionario tra i più significativi del XX scolo, connotata dalle atmosfere sospese, le luci filtrate; d’ispirazione romantica, dominata dal dissolvimento dell’”Io” nell’alienazione ed il dolore, la pittura di Fussli: penso, in particolare, ad una delle sue tele più celebri: “L’incubo”, raffigurante la personificazione del demone-incubo con le sembianze di una scimmia, seduto su una ragazza dormiente nella sua stanza. Degno di nota l’uso del colore e del chiaroscuro, il dominio delle ombre degli incarnati, l’illuminazione dai toni caldi della figura femminile.
Musica diegetica ed esplorazione dei ”perché espressivi”.
Da cineasta e cultore della musica nelle sue molteplici forme, sono da sempre sedotto dall’universo creativo che presiede alla composizione di un brano musicale, che abbia o meno la funzione d’integrare la valenza espressiva di una scena/sequenza. Nel primo caso si traduce in un intervento esterno alla svolgimento narrativo, ma non a quello filmico. Esiste, diversamente, una musica diegetica che vincola azioni/psicologie dei protagonisti ed attiene all’auricolarizzazione, la definizione del rapporto tra il “sentire” dello spettatore e il/i personaggio/i del racconto. E’ il caso dell’elemento musica nel racconto de “Il pianista muto”.
Scrivere (leggi: vedere filmicamente) – è stato detto – è un po’ come essere guidati dalla nostra musica interiore. Per quanto mi riguarda, seguire questa musica ha determinato l’esplorazione dei “perché espressivi” dei compositori i cui brani vengono eseguiti dal pianista muto, in stretta connessione con l’analisi dell’identità sconosciuta di quest’ultimo e quella riposta degli altri protagonisti del racconto. In tal modo, i mondi interiori e gli imput creativi dei primi, arrivano a sovrapporsi a quelli dei secondi, ne divengono analisi introspettiva. L’elemento sentimentale – l’espressione/rappresentazione dell’animo umano – viene così oggettivato, quanto i “perché creativi”. Potrei dire che l’espressionismo musicale, la carnalità mitigata dal misticismo di Listz, divengono – così come il “regno delle ombre” e l’oscuro passato, propri di Chopin – il misterioso mondo interiore del pianista muto; il romanticismo inquieto di Schumann, la sua eterna fanciullezza, traducono la passione d’amore ed i turbamenti di Nadine, quanto l’infelicità, i pensieri suicidi e la follia del musicista tedesco, rivelano il tragico vissuto dell’ex internato Rosenthal.
Il romanticismo spiccatamente individualista del musicista tedesco fu espresso mirabilmente nei suoi Lieder. Maestro ineguagliabile, tuttavia, della medesima forma espressiva – “ambientazioni sonore” che illuminano dei versi di canzoni di significati profondi – è stato Franz Schubert. Le note tragiche e spettrali del suo capolavoro “Winterreise”, evocazione dell’errare disperato di un amante, costituiscono una potente immagine simbolica del patimento esistenziale. Un mondo di fantasmi con cui è impossibile convivere, che trova rispondenza in alcune delle liriche di Goethe, ma anche di Herder e Shiller; autori verso i quali Schubert manifestò una particolare predilezione.
Immaginando un concerto per pianoforte come unicum espressivo con cui il protagonista svela le sue inquietudini e, a poco a poco, se stesso, dà vita alla silente ma emozionale corrispondenza con Nadine, desta le esistenze dei pazienti, potrei parlare di una partitura dei travagli interiori, dell’inconscio e dell’ottenebramento delle facoltà intellettuali, dello smarrimento nell’infinito e la “nostalgia del presente”, intesa come intimo desiderio di riappropriarsi delle realtà perduta; una musica, intrisa di tragedia e soavità, romanticismo e orrore, all’insegna del rapporto shellinghiano tra spirito e natura, tra Io mitizzato e finitezza umana.
In tal senso, se la pudìca intimità propria dell’opera di Schubert appare tanto diversa da quella morbosamente audace e frutto della tragedia interiore propria di Schumann – quanto la musica insondabile, a tratti torbida, espressione di un’esistenza quasi incorporea di Chopin è comparabile con quella di Liszt, principalmente per lo straordinario virtuosismo pianistico di entrambi – ritengo che nell’esplorazione dei perché espressivi di alcune delle loro opere sia possibile scorgere una comune voce dell’anima, connotata di passione e mistero. L’inquieta melanconia di “Sogno d’amore” e “Mephisto – Walzer (op. n.1 in Mi Bemolle Maggiore) di Listz, accomuna in qualche modo quest’ultimo a “Traumerei”/Sogno, dalle “Scene infantili” Op. 15, di Schumann – che pure non si può dire che sia stato amico del musicista ungherese – dedicate all’amata Clara. Allo stesso modo la grazia, che ne cela una profondità d’ispirazione, di “Notturno” n.2 (in Mi Bemolle Maggiore op.9) e “Preludio” (in Re Bemolle M, n. 15 – “La goccia d’acqua”) di Chopin, risultano così affini al malinconico romanticismo di “Serenata” (da “Schwanengesang”) di Franz Schubert; la tragicità senza speranza di “Winterraise, si rintracciano in “Marcia funebre” (nella sonata n.2 in Si Bemolle Maggiore, op. 35) ancora di Chopin. Si tratta di affinità, punti di connessione espressivi, nella direzione di quell’unicum di cui s’è detto.
Personaggi.
La descrizione delle identità ed i caratteri dei personaggi di seguito esposta, pur partendo da quella del romanzo, sviluppa – plasma – ciò che questa evoca. In altre parole, ognuno dei personaggi, “liberato” dalla costruzione letteraria, assume una più complessa verità nella rispondenza dei codici espressivi che riguardano un’opera cinematografica. Un procedimento che personalmente m’impegno a non disattendere, ogni volta che mi accingo ad elaborare delle note di regia a chiosa di un soggetto tratto da un racconto letterario.
Il pianista muto
“…Magro, piuttosto slanciato, pallido, eppure illuminato da un fuoco sfavillante negli occhi…Un’espressione sofferta ma forte in volto, l’andatura incerta: pare che cammini sollevato da terrà…Dà l’impressione di essere distratto, a disagio, come uno spirito che attenda il rintocco di un orologio ad annunciargli che deve ritornare nell’oscurità…”. E’ la descrizione di Franz Liszt, allora ventiduenne, fatta dalla contessa Marie d’Agoste che per lui lasciò suo marito; ma potrebbe attenere in modo altrettanto esatto alle sembianze – l’apparire agli altri – del pianista muto. Così come, sorprendentemente, sembrano appartenergli, fino quasi a farcene percepire la personificazione, il temperamento di Chopin: il mistero che avvolge la famiglia e la gioventù, il suo naturale talento pianistico insofferente all’osservanza di ferree regole di composizione musicale. Al contempo, nella direzione di quell’osmosi tra uomo e musicista, la figura del pianista muto esprime la dolcezza di esecuzione che fu di Schubert: quella ineguagliata capacità di sfiorare i tasti del pianoforte in virtù della quale produceva un suo suono cristallino. E ancora: il romanticismo che sfocia nel pathos, la passionalità focosa, i sentimenti intimi, lacrimevoli e sensuali, propri di Schumann.
Quando il misterioso personaggio, tra i venticinque ed i trent’anni, con indosso un frac liso che gli conferisce un fascino inquietante, viene rinvenuto su una spiaggia, nessuno può sospettare che egli serbi in sé il potere di “fermare il tempo”. Un potere che si esplica nel momento in cui accende il cuore di Nadine e ne determina l’attesa ragione di vita; coinvolgimento che assume i contorni della vertigine. Nessuno immagina cha la che la musica di questo ragazzo, silente come la spiaggia che lo ha strappato alle onde, sortisca l’effetto di perturbare l’animo umano. Nei silenzi profanati – un tempo sospeso fatto di attese e vuoti – risiede la sua contraddizione: un insieme di passione e controllo; sentimenti che si contrappongono fino ad annullarsi. “E’ come se un giorno qualcuno gli avesse rubato l’anima, lasciandogli solo la sua ombra”, citando un brano del libro “Presto con fuoco” di Roberto Cotroneo, un romanzo – come quello di Paola – attorno al mistero della musica e dell’essere al mondo.
Vorrei aggiungere che il “mio” pianista muto, così come sembra esprimere l’immagine sulla foderina del libro – l’autoritratto di Lino Frongia, i cui occhi e lo sguardo sono celati da un ramo – è una creatura che ha timore di sé, del suo misconosciuto presente/passato, e non sa rivelarlo neppure a se stesso, fin quando Nadine non riesce a rapirlo alla sua oscurità. E’ un essere in fuga dai suoi fantasmi. Ma è, soprattutto, l’immagine dell’”arbitrio esistenziale”; l’umana condizione di patimento e l’impossibilità di individuarne la ragione, nella quale l’unico conforto risiede nella certezza della dipartita: il solo evento che determina la fine definitiva, certa, d’ogni sofferenza.
Nadine
La prima immagine che se ne ha è quella di una ragazza dolce ed imbelle, rabbuiata dalla malinconia, come potrebbe esserlo una ventenne sottratta ai sogni e la spensieratezza dell’età dalla necessità di conquistarsi la propria indipendenza economica. Un’intima inquietudine che le si scorge nello sguardo quando si ritrova sola nella spiaggia deserta – il “mondo fuori” dove riappropriarsi dei pensieri – investita, come la sabbia immota, dall’impetuosità delle onde del mare in inverno.
Prestare il servizio d’infermiera presso la clinica psichiatrica è per Nadine l’incontro/confronto con chi è stato relegato ai margini della vita da un destino imperscrutabile, l’esperienza che mette a nudo le proprie fragilità attraverso le fragilità altrui. La ragazza affronta tutto questo con orgogliosa dignità, come una prova da affrontare per vincere quel timore di vivere che l’attanaglia da sempre.
Ella non si sottrae mai ai compiti assegnargli, svolge il suo lavoro con zelo esemplare, fin
quando non irrompe la figura del pianista, il suo mistero. E se fino ad allora Nadine – adottata dai suoi genitori all’età di dieci anni – ha vissuto la propria incompletezza con quieta rassegnazione, l’incontro con l’oggetto del suo sogno romantico, ne svela una passione che la investe e la travolge. Da spettatrice della propria vita, diviene protagonista di un sentimento che nasce e si alimenta dalla più struggente dell’illusioni: quella d’amore.
La passione di Nadine corrisponde ad una “sensualità interrotta”, che trae appagamento dalle proprie assenze, densa di bagliori ed oscurità. Così sorprendentemente affine all’indole di Chopin, tra gli autori prediletti dalla ragazza.
Ma se c’è una musicista, e la sua musica, che più di altri, che rivela l’identità più intima di Nadine, riporta alla luce i suoi ricordi (prima assopiti nella cassa lucida del pianoforte), questi è Robert Schumnn. La note del musicista tedesco sono state la proiezione della propria trascorsa vocazione musicale, frustrata dal peso della sconfitta senza appelli: quella di sua madre, pianista fallita, sfociata nel suicidio. Il perché, senza risposta, del trapasso e l’insensatezza dell’idea suicida, che ha finto per divenire l’ossessivo timore della vita nella ragazza, la sua affezione dell’anima.
Rosenthal
Se il temperamento ed il carattere di Nadine sono dominati dalla sete di un sentimento (amoroso) senza condizioni e quelli del pianista muto dall’apparente assenza di questo, l’indole di Rosenthal dalla rimozione del coinvolgimento emotivo/sentimentale. Perché se si è incapaci – o non lo si è più – di amare, non lo si è, talvolta, di odiare. Accade quando il ricordo di un’esistenza umiliata oltre ogni umana tolleranza, lascia il posto al silenzio, all’oblio che non risana ma anestetizza, all’”istinto che spinge un animale ad appiattirsi a terra per non essere schiacciato. Fingersi pietra. Anzi: diventare pietra”, citando un brano del libro. Scrive di Rosenthal il direttore della clinica ad suo collega: Tutto quello che ci è permesso fare è alleviare il suo sintomo, procurargli il sonno con mezzi artificiali; ma quanto a rimuovere le cause…Del resto, chi avrebbe la presunzione di guarire un uomo che è stato sottoposto ad un’esperienza simile”?: quella della negazione della dignità umana.
L’irrompere della musica del pianista muto coincide nell’anziano ebreo con il suo riaffacciarsi alla vita, anche se al prezzo di un “corpo a corpo” con il male ed il bene.
Tra i pazienti, Rosenthal è il solo che ami davvero la musica, che ne conosca le lusinghe, spesso pericolose. Così, con le note del pianista muto, riaffiora nella sua mente un sentimento che credeva di aver relegato, assieme al ricordo, nell’angolo più angusto della sua memoria: l’accoramento per aver fatto prevalere un disperato spirito di conservazione sulla propria umanità. Ma quando s’accorge che, nonostante tutto, ha serbato inalterato il gusto per la musica – lingua
materna e matrigna, al contempo, della nostalgia – torna ad assalirlo il sentimento di rimorso. Ecco, allora che, così come evocano le note di un celebre Lied della “Winteraisse” – il momento più struggente dell’esecuzione del compagno di prigionia Isaac: il suo commiato dalla vita – Rosenthal vede se stesso vagare disperato verso il nulla; ed è un lento, angoscioso, “viaggio d’inverno” verso l’autocondanna senza appelli: aspettare pervicacemente la propria fine.
Isaac
Il volto scavato, lo sguardo altrove, l’incedere incerto nonostante la giovane età: immagine di un tenace patimento interiore, oltre che fisico.
Analogamente al pianista muto, nulla è dato sapere di quel ragazzo così presente nel ricordo di Rosenthal: “il figlio della promessa”, come evoca il suo nome. Prima ancora della sua scomparsa,
ciò che è restato indelebile nella mente dell’uomo è il suo concerto per pianoforte, toccante e liberatorio per ognuno dei compagni di sventura; un inviolabile grido di libertà, la testimonianza che nessuno può attentare al coraggio dell’anima.
Attraverso la note del pianista muto la musica di Isaac diviene per Rosenthal, l’espressione vivida ed inquietante della grazia melanconica di Schubert, il suo male d’esistere.
La contessa
Fa parte, con Rosenthal, degli “eletti”: il drappello di abitanti del paradiso (ma sarà davvero paradiso? A volte mi vien fatto di dubitarne..) – cosi definisce il direttore della clinica coloro che, a dispetto degli altri pazienti, non fanno mai mancare la propria presenza nel giardino d’inverno: il loro controverso paradiso, ogni qualvolta che il pianista muto dà seguito alla sua esecuzione al pianoforte. Un musica che, agli orecchi della contessa, non ha nulla di umano; esprime la distaccata perfezione di un angelo e lo sconvolgente trasporto di un ossesso. Giacchè le sembra che pianista muto non si limiti ad eseguire un brano, ma arrivi ad crearlo dal nulla, o evocarlo da un remoto regno degli spiriti.
Nella gentildonna convivono l’austero contegno proprio del blasone ormai decaduto e la patetica nostalgia del tempo che fu; ne sono espressione il modo retrò e un po’ pittoresco di abbigliarsi e ingioiellarsi. Con la scomparsa del congiunto e la perdita dell’intero patrimonio, ella “non è più”; la donna affascinante ed ammirata, al punto da ingenerare pettegolezzi e chiacchiere maliziose sul suo privato, ha lasciato il posto alla propria estraneità al mondo.
La musica del pianista muto – il regno delle ombre che le note di una ballata di Chopin evocano nella donna – ha il potere di dare corpo alle sue visioni, frutto di una bizzarra commistione di fede ed occulto, allucinazioni e spiritismo, attraverso cui accedere al regno dei defunti. Una fuga dal presente che le risparmia i morsi dell’anima.
La signora Doyle
Sciatta, ordinaria, sinistra, è il personaggio più inquietante del ristretto novero degli abitanti del “paradiso”, che nel suo caso diviene l’inferno della propria coscienza. Lo prova il gesto di graffiarsi il dorso delle mani fino a farle sanguinare, quando le note del pianista hanno l’effetto di riaccendere il proprio insopprimibile rancore verso la vita e chi si è macchiato, ai suoi occhi, della colpa dell’inganno.
Il suo rifiuto inconscio della maternità – la persuasione che un ripugnate intruso abbia preso il posto del proprio figlio – esprime il buio della mente ma anche la doppiezza umana, la giustificazione della colpa. E’ la negazione del male, quando questo libera dalla prigionia dell’esistere.
Ciò che rende attuale il personaggio – il pensiero va agli infanticidi ad opera di madri, senza distinzioni di età e classi sociali, di cui ci parla la cronaca – è la lucida irrazionalità del suo gesto; la volontà di “difendersi” da chi ha la colpa di risiedere all’interno delle pareti domestiche, e per questo più malevolo.
Il signor Brown
Dai modi compìti e misurati, l’aspetto sobriamente elegante, sembrerebbe quasi un intruso tra gli “eletti”. La patologia da cui è affetto, del resto, appare più veniale rispetto a quella degli altri: una nevrosi sfociata in depressione, niente di più. In realtà l’uomo convive con mal di vivere più doloroso di quanto non si creda perché subdolo. E’ il malessere di una quotidianità all’insegna della vittoria del raziocinio sul sentimento.
Se l’attualità del personaggi della signora Doyle riguarda la drammatica propensione di talune donne/madri nel vedere un’insidia nel frutto della proprio ventre, quella di Brown attiene alla “banalità del dolore”; l’estenuante monotonia dello stare al mondo: un lavoro nel quale è bandito ogni barlume di fantasia, un’esistenza senza illusioni, né passioni. In questo grigiore esistenziale, non è un caso che sia proprio la musica (il ricordo, quasi onirico, del momento in cui una flebile, remota melodia prodotta da uno strumento a fiato, parve all’uomo nascere dal nulla) a contrapporsi fieramente alla logica, al caos improvviso dei numeri, da cui, diversamente, non è azzardato aspettarsi ordine e chiarezza.
E’ oltremodo significativo e toccante che il “senso delle cose e dell’essere”, ritenuto fin lì perduto, venga restituito ad un uomo che, all’opposto del personaggio di Rosenthal, si è sempre dichiarato insensibile alla musica: espressione del superamento della rappresentazione concettuale a beneficio della potere di fa sentire il sentimento e far immergere nella corrente vitale dell’essere.
Il direttore della clinica
Si tratta di uno psichiatra che non antepone, in senso stretto, l’ortodossia del sapere scientifico alle speculazioni della mente. Una propensione, tuttavia, che non lo sottrae dal rigore del medico.
Le note del pianista muto divengono per lui materia di studio scientifico, assieme alle sedute psicanalitiche attraverso cui i pazienti rivelano, anche in virtù del potere della musica, le proprie identità più riposte.
Eppure anche nel freddo uomo di scienza, si verifica una metamorfosi. Accade a seguito di
quella sconvolgente di alcuni pazienti e della stessa Nadine: la sua passione divorante per il pianista muto; il fugace ritorno alla parola di questi, ma foriero del sua definitiva scomparsa: inspiegabile come il suo rinvenimento; la rievocazione da parte di Rosenthal di un passato ed una verità rimossi, al prezzo dall’atroce scelta mettere fine ai suoi giorni.
Da questo momento lo psichiatra prende coscienza di aver fallito come medico: l’aver fatto prevalere in sé la routine terapeutica – “forma mentis” di scienziato confinato nell’angusto terreno della realtà empirica – lo schermo della nozione scientifica, sull’esplorazione del disagio spirituale ed il male dell’anima, divengono la sua autocondanna.
Le sue dimissioni dalla clinica sono la sua unica via di fuga.